|
|
|
|
|
 |
|
|
Questo fotogramma, ripreso da molti
giornali, è un perfetto esempio di immagine stupidamente
verticale: metà dello spazio è vuota, mentre manca l'informazione
essenziale di quanto sia lunga la fila di cinghiali e
quante siano le bestie a
spasso per le strade di Roma.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le fono-fotografie sono verticali, ma il mondo
è orizzontale |
| Lezioni di fotografia
N. 16 – 28 aprile 2025 |
 Precedente Precedente
 Successiva Successiva |
|
|
 Indice
delle lezioni Indice
delle lezioni |
Benvenuti,
anzi malvenuti, nell'era del mondo verticale. L'era in cui
una moltitudine di persone scatta miliardi di sedicenti fotografie, tenendo lo smartphone
– il fotòfono – in "posizione
telefono", cioè in verticale. Terrapiattisti a
novanta gradi. Ma lo sguardo
degli stessi fonofotografi vede naturalmente le scene
in orizzontale (tra poco vedremo perché).
Nei vecchi
manuali di fotografia non si parlava dell'argomento,
perché nessuno teneva la camera in verticale
quando la scena non lo richiedeva. Ma oggi il tema è
attuale, perché i fonofotografi scattano quasi
sempre con l'apparecchio in posizione "telefonica", cioè
verticale. Con risultati che,
nella maggior parte dei casi, non riescono a
raccontare una scena, perché ne hanno ripresa
solo una piccola parte. Come dimostra la foto qui a sinistra.Occorre
un'avvertenza: gli
argomenti che ho trattato nelle lezioni precedenti si applicano quasi
sempre sia alle foto sia ai video, ma questa lezione riguarda
soprattutto la
ripresa di immagini fisse, appunto di fotografie. E non di
immagini in movimento, cioè di video. Della scelta tra
immagine ferma e immagine in movimento, e di come
realizzare filmati decenti con lo smartphone, parlerò
nelle prossime lezioni.
Il punto essenziale è questo: noi vediamo sempre la realtà
in formato orizzontale, cioè come una scena più
estesa in
larghezza che in altezza. Questo dipende da due fattori:
primo, gli occhi degli umani sono affiancati e non sovrapposti;
secondo, il campo visivo è limitato dalla struttura del
viso, in alto dalle
arcate sopracciliari e in basso dalle guance. Mentre ai
lati non ci sono ostacoli significativi.
E' vero che spesso ci troviamo di fronte a scene che si
sviluppano in verticale, come quando guardiamo un
grattacielo; in questi casi è naturale la ripresa con la
camera in posizione verticale (foto qui sopra a destra).
|
|
|
|
 |
|
| Nell'immagine a sinistra lo
sguardo dovrebbe spostarsi in senso
orizzontale, ma lo smartphone riprende in verticale.
Solo quando per guardare il soggetto i nostri occhi
devono muoversi dal basso in alto, e viceversa, è
il momento di scattare una foto in formato verticale. |
|
|
|
|
|
|
Il dato di partenza è che la nostra visione
nitida copre un angolo molto più piccolo di quello totale
abbracciato dagli occhi: il campo totale si stende oltre i
180°. Invece il
campo nitido è intorno ai 40°-50°. All'esterno di
questa zona (in rosa nello schema qui a destra) la visione è
progressivamente "sfuocata" Per questa ragione, quando vogliamo
osservare bene tutta la scena che abbiamo davanti, dobbiamo muovere gli occhi a destra e a sinistra.
Invece l'obiettivo fotografico copre un angolo ridotto, in
funzione della lunghezza focale. Solo gli obiettivi
fisheye coprono in orizzontale un angolo di campo simile a
quello degli occhi che, come abbiamo detto, è meno esteso
in verticale, per la
struttura del viso. |
|
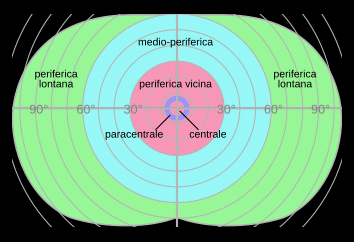 |
|
Lo schema qui a sinistra (tratto
da Wikipedia) illustra il campo visivo degli
umani. L'area azzurra corrisponde alla visione binoculare, cioè
l'area che viene vista dai due occhi; l'area rosa è quella in cui la
visione è abbastanza nitida; ; nell'area centrale c'è la massima
nitidezza ed è quella che serve per la lettura da vicino.
Il disegno è approssimativo. Altri studi indicano un'area nitida più
ristretta (da 40° a 50°), alla quale corrisponde – più o meno –
il campo inquadrato da un obiettivo "normale" da 50mm.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
L'esempio fotografico è forse più comprensibile dello schema. A
sinistra il campo intero coperto dallo sguardo, riprodotto
grossolanamente con il
fish-eye. A destra il campo che "vediamo" di fatto,
ignorando istintivamente le aree periferiche. Il campo effettivo varia
da individuo a individuo e forse, nella maggior parte dei casi, è
simile alle proporzioni di uno schermo televisivo 16:9.
Questa foto è scattata con un'ottica "normale" (50mm) e
dovrebbe rendere l'idea della differenza fra "vedere" e
"inquadrare" una scena.
|
|
|
|
| Ecco, nelle due
fotografie qui a destra, un
esempio di come l'inquadratura orizzontale possa essere molto più
efficace di quella verticale. Stessa scena, stesso punto di vista,
pochi secondi tra uno scatto e l'altro.
Il soggetto potrebbe suggerire la ripresa verticale (il personaggio in
piedi inserito visivamente nell'arco). Ma l'inquadratura non funziona,
perché c'è metà dello spazio totale che appare "sprecata".
Né il selciato né la (orribile) fascia in alto offrono informazioni
significative (se non che il cielo è coperto, ma per intuirlo basta
l'assenza di ombre portate).
Invece l'inquadratura orizzontale è "piena", non ci sono
aree vuote o insignificanti. Questa è una differenza sostanziale tra
una foto riuscita (anche se non è un capolavoro) e una foto che dice
poco o nulla.
Un altro dettaglio da considerare: nella foto verticale non si vede la
faccia del soggetto seduto, mentre in quella orizzontale si intuisce
il dialogo tra i due personaggi.
|
|

|
| Un altro dettaglio importante riguarda
l'angolo di campo: la foto qui sopra è scattata a una focale
leggermente più lunga, che consente di eliminare parti della
scena meno interessanti e concentrare l'attenzione sul
soggetto. |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| Bassa marea sulla costa della Bretagna. Due
foto, stesso punto vista, stessa dimensione dell'immagine
finale. Uno scatto in verticale, uno in orizzontale. Qual è
il più efficace, quale "racconta" meglio la scena?
Non c'è dubbio: è la ripresa orizzontale. Nella prima ci
sono più cielo e più terra, che non aggiungono nulla alla
scena. Mentre in orizzontale c'è uno sfondo che descrive bene
quello che ha "visto" chi ha scattato la foto.
Inoltre l'inquadratura orizzontale è ben composta: la massa della barca a
sinistra bilancia il peso del faro a destra (per questo
aspetto vedi anche La composizione come organizzazione di forme
visive).
Un consiglio per i fotografi da telefonino: dopo lo scatto
"automatico" in verticale, fatene uno con
l'apparecchio orizzontale. E poi fate il confronto... |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
| In questa coppia di vecchie foto è ancora
più chiara la differenza fra l'inquadratura verticale e
quella orizzontale. Stessa scena, stesso punto
di vista. Ma in orizzontale le masse scure danno un ritmo
visivo che è assente nello scatto in verticale: c'è
l'intenzione di descrivere lo spazio, di riprodurre quello che
vede il fotografo. In verticale si concentra l'attenzione su
un elemento e il contesto è meno evidente. |
|
|
|
|
 |
|
Fino a questo punto
abbiamo visto fotografie nel formato più comune, con un rapporto tra i lati (rapporto
d'aspetto) pari a 3:2 È il Full Format, il classico "formato Leica".
Ma oggi siamo abituati a un formato più ampio, il 16:9 dei
televisori. Spesso efficace anche nella fotografia, perché si
avvicina di più al campo visivo dell'occhio umano, come abbiamo
visto all'inizio di questa lezione. Un esempio è la foto qui
accanto, che ha il rapporto d'aspetto (aspect ratio)
di 16:9.
Ma oggi i telefoni cellulari, venduti e usati impropriamente come
macchine fotografiche, offrono rapporti d'aspetto ancora più
spinti. come il 19,5:9 e persino 21:9. Ottimi per le foto d'insieme
o i panorami,
naturalmente orizzontali, ma difficili da usare per le riprese
verticali, come si vede qui sotto.
|
|
|
|
 |
|
| Queste due fotografie in
"formato telefonico" dovrebbero illustrare la
differenza che c'è tra un'inquadratura orizzontale e una
verticale non casuale. In scenari come questo l'inquadratura
verticale non è sempre sbagliata, ma il fotografo deve
sceglierla a ragion veduta e non perché l'apparecchio di
ripresa, che resta un telefono, si impugna naturalmente in
verticale. Il rapporto d'aspetto di queste due foto è
circa 20:9. |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|